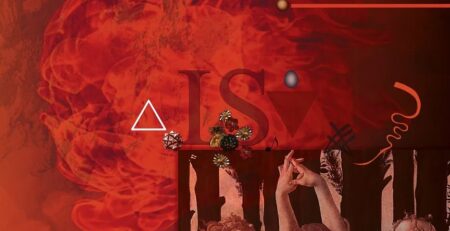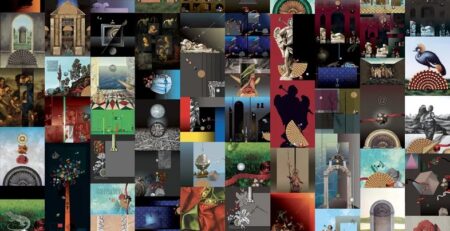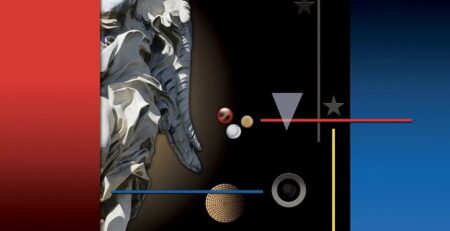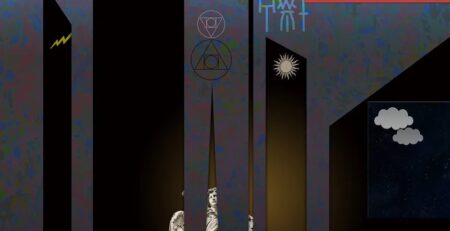Immaginare Leonardo
TRE MOSTRE COLLETTIVE DEDICATE A LEONARDO DA VINCI:
Castel Sonnino – Livorno
Palazzo Genovese – Salerno
Galleria Vittoria – Roma
LEONARDO
l’ultimo aristotelico e il primo ingegnere.
Philippe Daverio
LEONARDO FRA MARE, SCIENZA E ARTE
“Non si volta chi a stella è fiso”: questa è la frase che mi lega indissolubilmente a Leonardo Da Vinci; questo è il motto del sommergibile Da Vinci sul quale imbarcai da giovane Ufficiale di Marina nel lontano 1992, a La Spezia, dopo aver frequentato l’Accademia Navale di Livorno, conseguito la laurea in Ingegneria Navale Meccanica a Genova ed aver svolto il corso d’indottrinamento presso la Scuola Sommergibili di Taranto. Dieci anni d’imbarco, vissuti tutt’ad un fiato, seguiti da un ulteriore decennio di cantiere navale, fra collaudi, direzione lavori e prove in mare, per addivenire al mio attuale impiego nel mondo della Storia e dell’Arte. Tutto ciò senza aver mai scordato, purtuttavia, i miei pregressi trascorsi ingegneristici e quindi quell’approccio razionalista di cui Leonardo fu massima espressione, in ogni epoca, e soprattutto avendo sempre scolpito nella mia memoria quello straordinario aforisma vinciano che lessi poco più che ventenne, a chiare lettere plasmate in bronzo, sulla passerella del sommergibile Da Vinci e che da allora in poi ha istruito e diretto l’intera mia esistenza.
Ciò premesso, sarebbe stato un piacere iniziare a parlare, fin da subito, del genio artistico di Leonardo da Vinci: dalla pittura alla scultura, tenuto conto della mia pluridecennale militanza nel settore delle Arti Visive. Cionondimeno, in qualità di Direttore dell’Ufficio Storico della Marina Militare, di ufficiale di Marina e di ingegnere, propongo ai lettori di affrontare, almeno inizialmente, il tema leonardesco da un punto di vista diverso rispetto al tradizionale quadro, ben noto fin dal tempo delle scuole elementari.
Definire, semplicemente, Leonardo un genio è, oltre che banale, fuorviante. Nessuno, neppure lui, avrebbe potuto ideare o creare dal nulla le proprie opere nelle loro pressoché infinite applicazioni, spaziando dalla meccanica all’idraulica, dalla nautica all’astronomia, dalla matematica alla geometria, dalla fisica all’ottica, dall’architettura all’urbanistica, dalla botanica alla zoologia, dagli armamenti alla metallurgia, passando per l’anatomia, la fisica, gli studi del volo, quelli sulla circolazione del sangue, le macchine per l’intrattenimento ludico e molto altro ancora. In effetti, inventore eccezionale oltre che artista, questo protagonista, praticamente unico nei secoli nel suo genere, sapeva quel che faceva e pensava perché conosceva perfettamente lo stato della tecnologia del suo tempo.
Ed è proprio questo il settore e il panorama che mi propongo di descrivere, sia pure a grandissime linee, in questa fase iniziale di dissertazione perché è solo apprezzando correttamente quella che era la situazione a cavallo tra il Quattrocento e il Cinquecento che si può comprendere la vera portata, di per sé straordinaria, del progresso che Leonardo assicurò, nel campo della scienza, a beneficio di tutta l’umanità. Nessun uomo, lo ripeto, neppure lui, si muove né tantomeno si è mai mosso nel vuoto assoluto. In altre parole: tutti noi procediamo lungo un percorso assicurando, nel nostro piccolo, un progresso in quanto uomini di buona volontà. C’è chi compie balzi da gigante (e in questo caso siamo alla presenza di un colosso assoluto quale è il genio vinciano), ma il trampolino, comunque, esiste.
Vediamo, dunque, quale fu la base di partenza del nostro straordinario protagonista. La meccanica era, dalla metà del Trecento in poi, una specialità europea intendendo, con questo termine geografico, l’area compresa tra l’Italia, la Francia, il Belgio e la Germania occidentale. I cronisti bizantini, arabi, spagnoli e inglesi ammettevano infatti tutti senza difficoltà, tra il XIV e il XVI secolo, che era impossibile realizzare, da loro, opere – definite incredibili – come gli orologi meccanici e i cannoni. Si tratta di un accostamento apparentemente singolare tra i cannoni e gli enormi orologi pubblici, fiore all’occhiello delle città più moderne del tempo come, dal 1309, Milano, Genova, Bologna, Ferrara e, nel 1350, Pavia. Quest’ultimo era il più avanzato di tutti, un vero e proprio planetario, lodato e studiato da tutti gli astronomi del continente; Parigi seguì non meno di 20 anni dopo e Norimberga alla fine del secolo.
La definizione degli orologiai di quel tempo era, peraltro, quella, invariabile e standardizzata, di “magister bombardarum et horologiorum”. Orologi e cannoni erano, infatti, figli della stessa pianta, ovvero il frutto dei progressi della metallurgia conseguiti alla fine del Duecento in quelle stesse regioni dell’Europa continentale studiando, in maniera tutt’altro che empirica, le proprietà dei vari tipi di rame ed acciaio, oltre alla dilatazione termica dei metalli e ai fenomeni di elasticità, resistenza, compressione e strappamento. Ciò aveva permesso di realizzare, a un tempo, sia i nuovi meccanismi, dalle ruote dentate alle catene fino ai ritardatori e alle molle, sia le canne e gli affusti dei primi pezzi d’artiglieria. L’archeologia subacquea ha dimostrato che si trattò, in realtà, di una riscoperta, in quanto l’incredibile macchina di Anticitera, un sofisticato calcolatore meccanico risalente al terzo secolo avanti Cristo e utilizzato dai marinai di quel tempo per la navigazione d’altura, disponeva già delle necessarie ruote dentate realizzate in lega. Si trattava, però, di una tecnologia nota, nell’antichità, a solo poche dozzine di persone per generazione le quali si tramandavano gelosamente i relativi segreti da padre in figlio e scomparsa, nei secoli bui successivi alla caduta di Roma, fino a perderne lo stesso ricordo.
Ed è a questo punto della storia che l’uniforme che indosso assume il proprio pieno significato. La nave, qualsiasi nave del proprio tempo, è – da sempre – il più sofisticato, avanzato e diffuso prodotto tecnologico del momento. Anche le odierne imprese spaziali non sono che un sottoprodotto, regolarmente in ritardo, di questa realtà. Analogamente le missioni della Marina non cambiano mai, si tratti della difesa dello Stato e della sua economia (il 90% del valore del traffico italiano e mondiale avviene sui mari) o dell’assistenza umanitaria. Mi permetto infine di citare un nome per tutti: Plinio il Vecchio, l’erudito per eccellenza e ammiraglio di Roma, morto al comando della flotta di Capo Miseno e del Mediterraneo occidentale in occasione del soccorso immediatamente prestato (perché nulla è più rapido, capiente, già organizzato e sempre pronto come le navi di una Squadra) delle popolazioni di Ercolano e Pompei in occasione dell’eruzione del Vesuvio del 79 dopo Cristo.
Gli orologi nacquero, pertanto, per esigenze navali evolvendo infine, nel Settecento, nei moderni cronometri, indispensabili per il calcolo della longitudine. I primi cannoni furono studiati per essere utilizzati anch’essi a bordo delle navi e vennero impiegati, per la prima volta, a Southampton, nel 1338, quando i genovesi abbatterono, a cannonate, la grande e, apparentemente, impenetrabile porta dal mare in bronzo di quella città, per poi irrompere e conquistarla nel corso della Guerra dei cent’anni.
Leonardo, uomo di genio, utilizzò al meglio la tecnologia disponibile al tempo intuendo applicazioni nuove e originali in buona parte indirizzate – non a caso – verso l’ambiente marino e fluviale, si trattasse di sommergibili, draghe, scafandri da palombari, traghetti, imbarcazioni a pale, dei navigli milanesi, di canali e opere idrauliche varie, anche colossali, e dell’architronico, nucleo fondamentale della macchina a vapore che non ebbe il tempo, purtroppo, di sviluppare.
Non creò dal nulla ma proseguì a passi da gigante, conviene ripeterlo, l’eterno progresso dell’umanità trovando, nel mondo a cui mi onoro di appartenere da ufficiale, ingegnere e uomo, la creta, la balsa e forse qualcosa di più, con cui realizzare i propri modelli.
Ciò premesso, noi sappiamo benissimo che Leonardo si occupò pressoché di tutto, che scoprì o inventò tutto o quasi, ma, diciamolo francamente accettiamo queste cose esattamente come accettiamo che Prometeo rubò il fuoco agli Dei, cioè facendo entrare Leonardo nella categoria dei miti.
Ma non solo, questo incredibile scienziato toscano fu anche un immenso pittore. Basti pensare che sia le teorie scientifiche relativiste einsteiniane, come pure il cubismo pittorico picassiano, furono un’ineludibile conseguenza del razionalismo leonardesco, preconizzatore – per dirla alla Alfred Barr – del filone razionalista afferente alla Non Geometrical Abstract Art. Inoltre nei ritagli di tempo Leonardo dava anche preziosi consigli e insegnamenti di architettura ai vari Le Corbusier e ai Nervi della sua epoca: basti pensare all’uomo vitruviano, alla sezione aurea, passando per lo sviluppo urbanistico della città ideale, le idrovie e le chiuse idrauliche, le fortezze inespugnabili, i ponti girevoli e altro ancora.
Tornando all’argomento della sua pittura il profano ha sentito spesso parlare di sfumato, di composizione piramidale, di atmosfera misteriosa e inafferrabile, di compenetrazione tra luce e ombra. Tutte queste cose esistono, è vero, ma costituiscono tutt’al più la superficie o i mezzi tecnici dell’arte leonardesca che esprime qualcosa di altro, di irripetibile, di particolare ed universale al tempo stesso. L’artista Leonardo dice, infatti, a tal proposito che il pittore è “signore d’ogni sorta di gente e di tutte le cose” e che “la deità che ha la scienza del pittore fa che la mente del pittore si trasmuta in una similitudine di mente divina”.
Ecco, dunque, il vero valore dell’opera vinciana mossa dalla coscienza della mutevolezza della realtà fenomenica, esattamente analoga a quella che lo scienziato ebbe fortissima della mutevolezza della realtà fisica. Qui risiede la grandezza assoluta di Leonardo Da Vinci: Homo Novus rinascimentale ad litteram; ossia Uomo Universale che sviluppa pienamente le facoltà dategli da Dio, che conosce a fondo le arti più diverse, le domina e le coltiva scientemente e che si avvicina il più possibile nel soggiogare la terra a sé, lasciandosi alle spalle l’eredità medievale dell’umana sottomissione dell’Immanente al Trascendente e della perenne espiazione terrena della carne, in forza del peccato originale, come preparazione a una vita posteriore alla morte, come mezzo di raggiungimento della salvezza eterna. Con Leonardo, più che ogni altro, si ribalta questa visione del mondo d’impronta medioevale, la Ragione prende il sopravvento sull’Emozione, o quantomeno inizia a competere con Essa ad armi pari, spalancando così le porte a Spinoza, al Razionalismo filosofico e all’Illuminismo, da cui discende la Società Moderna.
Si parla, dunque, del pittore e la mente corre insieme al pensatore e ciò è dovuto al fatto che il genio del pittore e quello dello scienziato si sommano senza soluzione di continuità. Se in aggiunta a ciò siamo disposti ad ascoltare le testimonianze storiche di persone degne di fede che ci riferiscono che solo in fisica pura , in meccanica ed idraulica Leonardo è titolare di oltre centocinquanta studi organici che più tardi perfezioneranno Galileo, Huyghens, Pascal, Newton e Coulomb e che avrebbe potuto depositare un centinaio di brevetti; se pensiamo che Egli fu prima di Bacon il vero assertore del metodo sperimentale da cui è nata tutta la nostra civiltà, allora comprenderemmo veramente la grandezza immensa di Leonardo Da Vinci; tornando così a Prometeo e quindi al mito universale.
L’universalità rappresentava, del resto, per Leonardo l’ideale di una formazione completa, eclettica, e già formulata nell’ellenismo da Enciclio nella sua Paideia. Un’universalità che si manifesta palesemente non appena si tenta di risalire dai risultati alle premesse e al tipo di rapporto ch’Egli instaura tra Pratica e Teoria, e più largamente tra Arte e Scienza: perché la Scienza vale sì, in primo luogo, a designare il rigore metodologico che lo scienziato Leonardo esige dal Leonardo pittore, ma subito dopo gli pone anche il problema di una nozione scientifica della natura stessa. E questa natura, elevata a scienza e tanto più amata quanto più svela la matematica necessità dei suoi comportamenti, fornisce il fondamento stesso della sua concezione del mondo, diventando altresì il tema primario della sua ricerca e il contenuto stesso della sua visione di pittore e di scienziato.
Del resto Leonardo è l’uomo che disse “facil chosa è farsi universale”. Egli possedeva, infatti, una curiosità inestinguibile, che era poi quella del suo stesso secolo, e possedeva il furore di estinguerla. Egli vedeva il nesso fra cose lontane e che al comune distratto mortale appaiono del tutto distinte, autonome. Sotto i suoi occhi il mondo si stendeva in tutta la sua complessità e al contempo la sua mente ne spiegava le ragioni e ne smontava il meccanismo; lo spazio si riempiva così di tutte le relazioni, di tutti i movimenti e delle tracce che lasciavano questi movimenti. Il termine “grossezza dell’aria”, spesso utilizzata da Leonardo, è da intendersi al contempo come l’atmosfera sia piena di palpiti naturali e sia come la rappresentazione pittorica del mondo non possa avvenire senza un costante incontro-penetrazione con la Natura, correlata allo stupore che si rinnova davanti ad essa: dal macrocosmo celeste al microuniverso dell’intimità. L’artista-scienziato Leonardo diventa così un pioniere dell’ignoto, un’avanguardista del Sapere, in un’epoca costantemente assetata di Assoluto.
Venendo, poi, ai secoli più recenti, la sua influenza fu enorme e determinante. La sua concezione della grossezza dell’aria, la sua ombra, il suo sfumato, stanno alla base del colorismo veneto, di Velasquez, di Rembrandt, degli Impressionisti. Giungendo poi al secolo breve, Cubismo, Futurismo, Pittura Astratta, Surrealismo, Suprematismo, e molto altro ancora, non sono altro che i tentativi per rappresentare quelle intime connessioni dell’essere umano con l’Universo e l’Assoluto che Leonardo, scienziato e pittore, intuì e seppe ricreare nel volto ineffabile della Gioconda, nella Vergine delle Rocce, come pure nell’Annunciazione, nell’Ultima Cena e in molti altri suoi capolavori.
Certamente la straordinaria qualità innovatrice di quella concezione e visione, che fece del naturalismo o scientismo leonardesco l’atto di nascita della scienza moderna – non fosse altro per la chiarezza con la quale egli intuì la relazione tra fenomeno, legge e riporto sperimentale – comportò una vera e propria rivoluzione, che si protrae tutt’ora, all’interno dell’eterno problema dei rapporti tra Arte e Realtà. Cita Leonardo a proposito “la pittura rappresenta al senso, con più verità e certezza le opere di natura”. Con questa affermazione il genio vinciano – che perfeziona gli esperimenti Quattrocenteschi sulla prospettiva, mettendone allo studio ulteriori tre: prospettiva delle diminuzioni dei corpi in distanza, dei colori, e prospettiva aerea – pare realizzare il sogno superbo d’un pieno dominio figurativo del reale: ossia risalire dall’esterno d’una natura solo rispecchiata e mimesi del dato reale, verso l’interno di una natura indagata nelle sue cause, attraverso il metodo sperimentale, che traduce i problemi dell’imitazione dell’arte in problemi di conoscenza e di scienza.
Ammiriamo, dunque, l’uomo come ammiriamo la sua somma creatura, la Gioconda, con la mente per un attimo tormentata da mille interrogativi, e ce ne discostiamo perché gli interrogativi sono troppo complicati, pur essendone straordinariamente affascinati, dal riflesso dell’idea pura di emozione, di bellezza, in cui tutte le realtà si fondono, si contengono e si sublimano. Del resto “la bellezza ha tanti significati quanti stati d’animo ha l’uomo”, citava Oscar Wilde, e renderli manifesti attraverso la narrazione della propria opera significa esplicitare il resoconto di un’anima. Un’anima che sublima a sé una storia durata più di ventimila anni, completa di esperimenti e provocazioni, suddivisa in atti e scene con ricche caratterizzazioni, ribaltamenti, intuizioni, improvvisazioni, colpi di scena e catartiche riflessioni, quale quella proposta dallo spirito innovatore, unico, assoluto e irripetibile di Leonardo da Vinci.
Livorno, 2019
Giosuè Allegrini – Storico dell’Arte